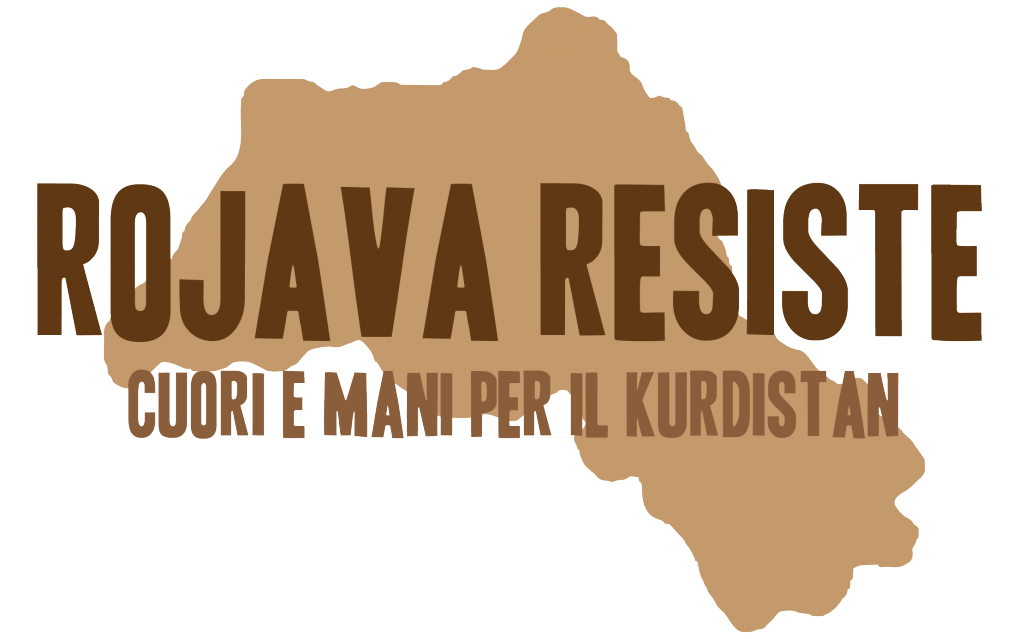Inauguriamo oggi la pubblicazione “a tappe” di una tesi che riflette sul conflitto curdo-turco.
Buona lettura.
Un conflitto lungo un secolo
Prima parte
Il conflitto curdo-turco, dopo un periodo di tregua tra la guerriglia del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e l’esercito di Ankara, è tornato a far parte della cronaca giornalistica, a causa soprattutto del protagonismo conquistato dai curdi del Rojava, nella guerra civile siriana e nella resistenza contro Daesh (lo Stato Islamico). È fatto noto e dichiarato che il Partito dell’Unione democratica (Pyd) e i suoi bracci armati Unità di difesa del popolo (Ypg) e Unità di difesa delle donne (Ypj) sono affiliati, ideologicamente e organizzativamente, al più vecchio movimento di liberazione curdo-turco. La fratellanza dei curdi dai due lati del confine e gli interessi di Ankara nel conflitto siriano hanno riacceso le spinte autonomiste anche nel Bakur (Kurdistan settentrionale, Turchia).
In secondo luogo, bisogna considerare la fase di instabilità interna che la Turchia sta vivendo con particolare intensità dal 2013: il riesplodere di movimenti sociali e sindacali, a partire dalla rivolta di piazza Taksim, e il progetto di riforma autoritaria del paese da parte del presidente Tayyip Erdogan, si sono intrecciati con i fronti caldi internazionali; storicamente, quando la Turchia ha attraversato momenti di polarizzazione politica, una delle carte utilizzate dai governi è sempre stata la “destabilizzazione nell’est”, ovvero la questione curda come elemento sovversivo e di pericolo per l’integrità nazionale. Questo appare ancora più vero nei mesi seguito al tentativo di golpe il 15 luglio 2016, da parte di settori anti-erdoganiani dell’esercito, cui ha fatto seguito, con la sconfitta dei militari ribelli, il controgolpe del governo che definitivamente chiuso gli spazi di agibilità democratica nel paese; sebbene il conflitto interno sia identificabile tra erdoganiani e gulenisti (sostenitori di Fetullah Gulen, l’imam in esilio negli Usa, padrino politico ed ex alleato di Erdogan, da anni in rotta con il suo vecchio pupillo), interpretabile come una sorta di guerra civile interna a segmenti del potere, la violenza repressiva si è scagliato anche contro le opposizioni di sinistra e i curdi in particolare.
Quando si parla del conflitto curdo-turco, però, si tende a interpretarlo unicamente alla luce della categoria del conflitto etnico-culturale. A nostro avviso, una lettura che non tiene conto della sua storicità e lo prolunga indefinitamente nel tempo, quasi fosse sempre esistito. In realtà, si tratta di un conflitto relativamente recente: curdi e turchi hanno vissuto per secoli in pace all’interno dell’Impero Ottomano e, dall’Ottocento in avanti, con la sua riduzione territoriale progressiva hanno stretto un patto di stabilità quando i curdi sono divenuti il terzo gruppo etnico dell’Impero (dopo turchi e arabi) e il secondo dell’Anatolia. È stato dopo la guerra di liberazione del 1920-22, con la fine del “Patto nazionale kemalista” che i curdi sono stati espulsi dalla Grande Assemblea di Turchia e di fatto ridotti alla condizione di “turchi della montagna”, considerati arretrati economicamente e culturalmente. Il problema è quindi anzitutto politico: si tratta del contratto sociale mancato o razzialmente definito al momento della fondazione della Repubblica.
Alla luce della teoria interpretativa di C. Tilly e S. Tarrow esposta ne La politica del conflitto (2007), quello tra curdi e governo turco può essere interpretato come un conflitto letale, con tratti comuni di conflitto inter-etnico, guerra civile e lotta rivoluzionaria; il contesto all’interno del quale si sviluppa (la Repubblica di Turchia) rientrerebbe nella categoria di regime composito (che prevede al suo interno diversi gradi di democraticità e spazi di libertà politica diversificati su base discriminatoria), sebbene forse una definizione più calzante anche per il suo lato democratico possa essere quella di democrazia protetta, a causa del ruolo centrale avuto dall’esercito nella vita politica soprattutto fino agli anni Novanta del secolo scorso. Infine, sicuramente un elemento da considerare è la permanente internazionalizzazione del conflitto curdo-turco: un popolo diviso in 4 stati dai trattati successivi alla Prima guerra mondiale (Turchia, Iraq, Iran e Siria) e, in particolare, un’azione conflittuale su vasta scala in Turchia, paese chiave per l’Alleanza atlantica dalla Guerra fredda fino ad oggi; tutto questo ha legato in modo obbligato le forme e i risultati del conflitto curdo-turco al contesto regionale e agli equilibri geopolitici.
Possiamo distinguere almeno quattro cicli nel flusso di conflitto, con le seguenti caratteristiche:
-
1924-1937: negazione legale, politica e culturale dell’esistenza del popolo curdo da parte di Ankara, applicata manu militari; opposizione curda espressa in forma di rivolta tribale, sebbene con ampio seguito tra la popolazione, da parte dei clan e di un nascente movimento nazionalista in senso moderno.
-
1961-1978: è il periodo che potremmo definire di “gestazione della politica” da parte del movimento nazionalista curdo, rappresentato per lo più da intellettuali e organizzazioni culturali; grande influenza ha il movimento curdo-irakeno, tramite il Partito democratico del Kurdistan-Iraq (Pdk-Iraq). Molto importanti sono le vicende nazionali turche che, dopo il golpe del 1960, vedono il contesto politico polarizzarsi e la questione curda diventare progressivamente parte del patrimonio del movimento sindacale e della sinistra rivoluzionaria turca. Dopo il golpe del ’71 e la disfatta della rivolta del Pdk in Iraq, nascono numerosi partiti politici curdi. Lo Stato ha continuato a rispondere attraverso leggi discriminatorie, repressione militare e giudiziaria, vere e proprie tecniche di genocidio.
-
1980-1999: è il periodo del conflitto letale vero e proprio, che vede la maggior conflittualità tra le due controparti e può essere diviso in due sottofasi: a) ’78-’88 e b) ’90-’99.
Durante la prima si ha l’inizio vero e proprio della lotta armata, in patria e in Europa (data l’ampia presenza, in particolare in Germania, di comunità turche e curde), da parte del Pkk; una politica governativa fondata non solo sulla tradizionale repressione militare e giudiziaria, ma anche sui metodi della guerra sporca (che proseguono anche al giorno d’oggi). La seconda, invece, vede un’apertura da parte di settori dello Stato e della leadership del Pkk, che non si tradurrà in un vero e proprio processo di pace a causa della cattura di Abdullah Ocalan.
-
2009-oggi: il fallimento dei negoziati tra Pkk e Stato turco nel 2009-2011, le politiche autoritarie promosse dal 2011 dai governi Erdogan e la cosiddetta sirianizzazione del Bakur con l’inizio della guerra civile oltre confine, hanno riacceso il conflitto; questo, però, non vive solo di lotta armata e sommosse urbane, ma anche e soprattutto di campagne politiche nazionali e internazionali da parte delle molte organizzazioni legate al movimento curdo.
Possiamo notare delle somiglianze con altri conflitti e contesti sviluppatisi del Novecento, in particolare l’Irlanda (come esempio di conflitto letale) e Israele (in quanto regime composito). Ma anche e soprattutto delle differenze: perché la storia del conflitto curdo-turco è meno antica di quello anglo-irlandese e, soprattutto, non può essere considerato un contesto pacificato; rispetto a Israele e ad altri regimi con differenti gradi di democrazia interna, invece, serve a nostro avviso utilizzare la categoria già accennata di democrazia protetta, avendo rappresentato militari e apparati di sicurezza un polo di potere indipendente e sovrano rispetto all’architettura democratica ufficiale.
È possibile inoltre applicare criticamente meccanismi e processi nel lungo flusso di conflitto, a seconda degli episodi e degli eventi caratteristici di ciascun ciclo. Vedremo allora l’estrema complessità del conflitto all’interno del regime turco che non permette, a nostro avviso, di leggere un solo tipo di conflitto per volta, ma invece più forme conflittuali. Questo grazie soprattutto alla diversificazione strategica scelta dal Pkk e dal movimento di liberazione ad esso legato, all’instabilità interna della Turchia e, nel periodo più recente, all’internazionalizzazione della questione curda.
To be continued